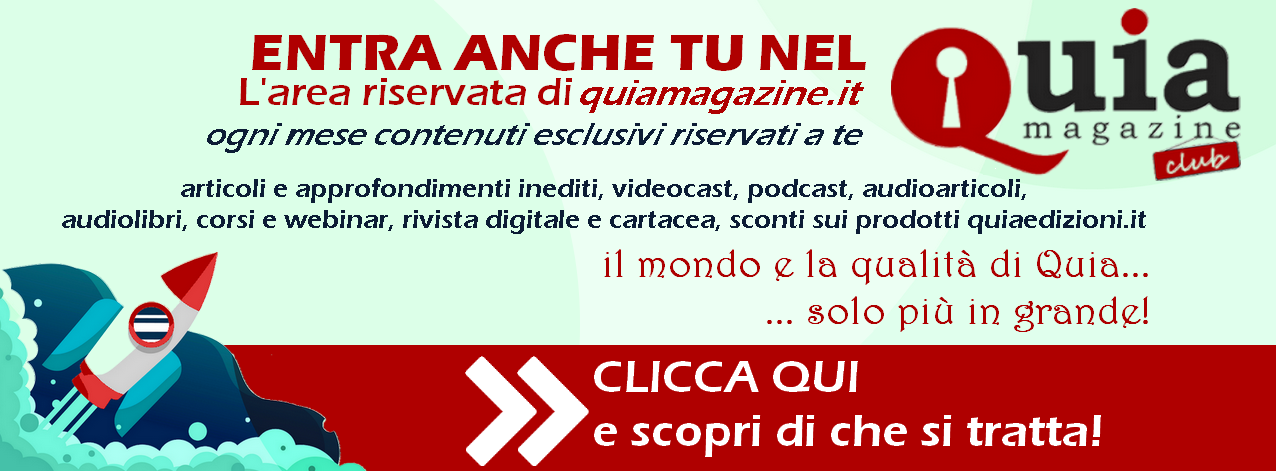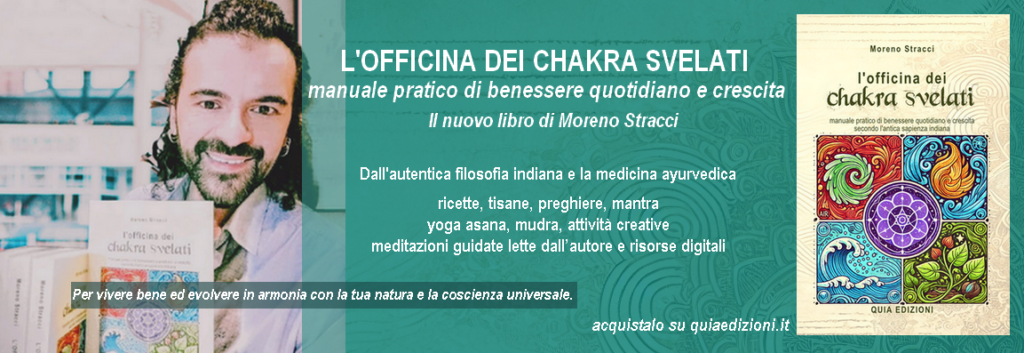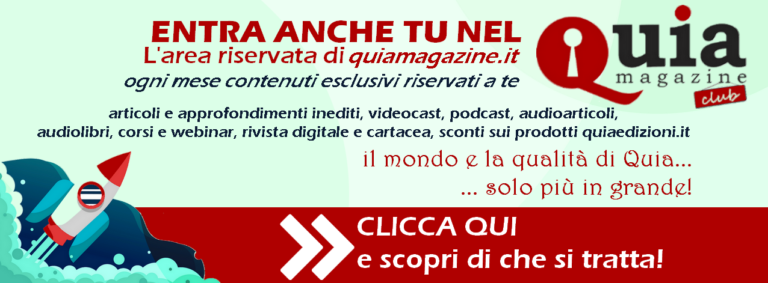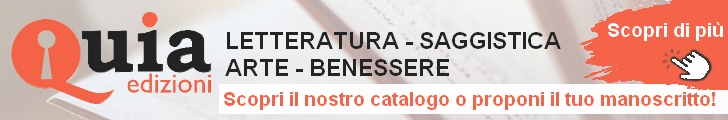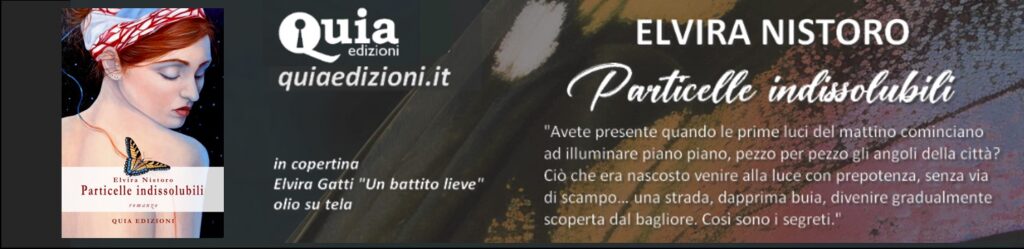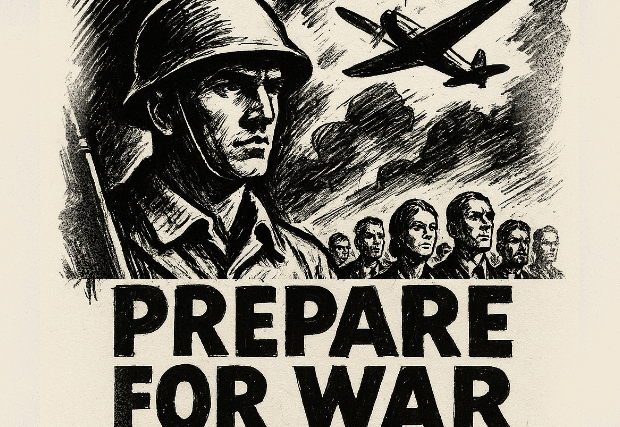SPECIALE: Nati cuccioli “Metalupo” grazie all’Editing Genetico

di Chiara Morelli
La recente notizia del “ritorno in vita” del metalupo, il canide estinto che ha ispirato le creature di “Game of Thrones”, ha suscitato molto interesse, ma è importante fare chiarezza su cosa è realmente accaduto: si tratta veramente di un processo di de-estinzione?
Tre nascite “miracolose”
I tre cuccioli nati ad opera degli scienziati della Colossal Biosciences, sono stati chiamati Romolo e Remo (nati a ottobre 2024) e Khaleesi (nata a gennaio 2025).
Romolo e Remo, come riportato dallo stesso sito ufficiale, si comportano proprio come dei cuccioli qualsiasi: giocano a rincorrersi, si mordicchiano affettuosamente e si strusciano il muso l’uno contro l’altro. Però, guardando questi cuccioli bianchi che adesso hanno sei mesi, c’è qualcosa che non quadra con l’immagine tipica di un giovane animale: le loro dimensioni, tanto per cominciare. Nonostante la giovane età, sono già lunghi quasi un metro e venti, pesano trentasei chili e potrebbero crescere fino a raggiungere un metro e ottanta e un peso di sessantotto chili. Poi c’è il loro modo di fare: quella gioiosa esuberanza che i cuccioli di solito mostrano con le persone – correndo incontro per farsi coccolare, grattare la pancia e dare bacini – in loro è completamente assente. Mantengono le distanze, tirandosi indietro se qualcuno si avvicina troppo. Addirittura uno degli addestratori che li ha cresciuti fin dalla nascita può avvicinarsi solo fino a un certo punto prima che Romolo e Remo si spaventino e si allontanino. Questo non è il comportamento di un cane domestico, ma quello di lupi selvatici: questi cuccioli sono lupi. Anzi, sono metalupi, il che spiega perché si sentano così distanti.
Non si tratta di una vera e propria de-estinzione del metalupo originale
L’azienda di biotecnologie Colossal Biosciences ha annunciato la nascita di questi tre cuccioli che presentano tratti fenotipici simili ai metalupi, come dimensioni maggiori e pelliccia bianca. Questi cuccioli sono stati ottenuti attraverso un processo di editing genetico su lupi grigi. I ricercatori hanno apportato circa 20 modifiche su 14 geni del DNA dei lupi grigi, utilizzando come “modello” il DNA del Canis dirus (il vero nome scientifico del metalupo estinto). Il materiale genetico modificato è stato poi inserito in ovociti di lupo grigio, e gli embrioni risultanti sono stati impiantati in madri surrogate (cagne meticce di grossa taglia).
Qui maggiori informazioni sul metalupo direttamente dal sito della Colossal

Il DNA per l’esperimento
Gli scienziati di Colossal Biosciences hanno utilizzato il DNA antico estratto da resti fossili di Canis dirus per il loro progetto. In particolare, hanno analizzato il DNA proveniente da un dente fossile di circa 13.000 anni trovato in Ohio e da un teschio fossile di circa 72.000 anni che hanno fornito il materiale genetico per la ricostruzione del genoma del metalupo.
È importante notare che il DNA antico è spesso degradato e frammentato, rendendo complesso il processo di ricostruzione dell’intero genoma. Gli scienziati di Colossal Biosciences hanno dovuto utilizzare tecniche avanzate di sequenziamento del DNA, tecniche di ingegneria genetica (come CRISPR/Cas9) e bioinformatica per assemblare il genoma del metalupo a partire da questi frammenti antichi. Questo genoma ricostruito è stato poi utilizzato come riferimento per apportare modifiche genetiche alle cellule di lupo grigio.
Il dibattito sulla de-estinzione
Indubbiamente il risultato raggiunto dagli scienziati di Colossal Biosciences è una meraviglia di ingegneria genetica, ma la prospettiva di riportare in vita specie estinte come il metalupo innesca un acceso dibattito che intreccia considerazioni etiche, implicazioni sociali e potenziali conseguenze ecologiche.
Dal punto di vista etico, sorgono domande sulla nostra responsabilità di “giocare a fare Dio” e sulle difficoltà che individui de-estinti potrebbero affrontare in un mondo profondamente cambiato rispetto al loro tempo. Socialmente, l’entusiasmo per il ritorno di creature iconiche si scontra con la necessità di investire risorse significative, potenzialmente distogliendole dalla conservazione di specie ancora esistenti e minacciate. Sul piano ecologico, i timori riguardano l’impatto che specie de-estinte potrebbero avere sugli ecosistemi attuali: potrebbero diventare invasive o peggio aliene, alterare equilibri consolidati o persino trasmettere patogeni sconosciuti. Pertanto, ogni progetto di de-estinzione richiede una valutazione multidisciplinare rigorosa, bilanciando il fascino della resurrezione con la necessità di reimmettere specie estinte nell’ambiente naturale attuale e la prudenza necessaria per proteggere la biodiversità presente e futura ma anche lo stesso uomo.
Neo-Conservazione Biologica delle specie in pre-estinzione
Nel caso di specie minacciate direttamente dalle attività umane, e non da processi evolutivi naturali o cambiamenti ambientali su larga scala, il processo di de-estinzione raggiunto dalla Colossal Biosciences potrebbe rappresentare invece un valore aggiunto significativo, seppur complesso. Allora se pensiamo a “riparare” il danno causato dall’uomo come la caccia eccessiva, la distruzione degli ambienti naturali, l’introduzione di specie aliene in un determinato ambiente o l’inquinamento, la de-estinzione – o potrei chiamarla in un’ottica più ampia, Neo-Conservazione Biologica, visto che parliamo di animali ancora non completamente estinti – potrebbe essere il perfetto alleato per ripristinare quegli equilibri biologici perduti a causa di un’azione antropica aggressiva e incontrollata.
Quando e perché si è estinto il Metalupo
Ingegneria genetica a parte, quado e perché si è estinto questo animale?
Il Canis dirus, comunemente noto come metalupo o “lupo terribile”, si è estinto alla fine del Pleistocene superiore, durante l’evento di estinzione di massa del Quaternario. La data precisa dell’estinzione è ancora oggetto di dibattito, ma la maggior parte delle stime indica un periodo compreso tra 16.000 e 10.000 anni fa.
Quando parliamo di come mai il metalupo – ma anche altri animali – si sia estinto, dobbiamo immaginare uno scenario piuttosto complesso, con diverse cause che probabilmente hanno giocato un ruolo combinato che ha portato a una perdita di chance evolutive e poi alla scomparsa. La risposta univoca né definitiva però gli scienziati hanno individuato alcuni fattori principali che potrebbero aver portato alla sua scomparsa.
Innanzitutto, c’è da considerare il grande cambiamento climatico che segnò la fine dell’ultima era glaciale. Immaginiamo le temperature che salgono, gli ambienti che si trasformano: tutto questo ha sicuramente avuto un impatto sugli ecosistemi e, di conseguenza, sulla disponibilità delle prede di cui il metalupo si nutriva abitualmente.

Difatti l’altro aspetto cruciale è l’estinzione della cosiddetta megafauna. Il metalupo era un cacciatore di bestioni, come bisonti, cavalli selvatici e bradipi giganti. Se queste grandi prede hanno iniziato a sparire – e anche qui, i cambiamenti climatici e forse l’arrivo dell’uomo con le sue attività di caccia hanno giocato un ruolo chiave – è logico pensare che il metalupo si sia ritrovato con sempre meno cibo a disposizione.
Non dimentichiamoci, inoltre, della possibile competizione con altri canidi, in particolare con il lupo grigio. Quando quest’ultimo è arrivato e ha iniziato a diffondersi in Nord America, potrebbe aver innescato una lotta per le risorse, e magari il lupo grigio, con le sue dimensioni ridotte, aveva qualche vantaggio in più nella caccia a prede più piccole, che ha messo in difficoltà il metalupo.
Infine, non possiamo escludere del tutto la possibilità che anche delle malattie abbiano contribuito al declino della popolazione di metalupi, proprio come succede oggi con molte specie.
L’estinzione è un processo complesso e raramente è dovuta a una singola causa. Molto probabilmente, una combinazione di questi fattori ha portato alla scomparsa del Canis dirus, come anche per altre specie.
Habitat e distribuzione
Il Canis dirus (metalupo) abitava principalmente il Nord America durante il Pleistocene superiore. I suoi resti fossili sono stati ritrovati in un’ampia area che si estendeva dal Canada meridionale fino al Messico.
Sebbene la maggior parte dei ritrovamenti si concentri in Nord America, ci sono anche alcune evidenze della presenza del Canis dirus in Sud America, in particolare lungo le coste occidentali e settentrionali, con ritrovamenti in paesi come Venezuela, Cile, Perù e Bolivia.
La distribuzione geografica del metalupo suggerisce che era adattabile a una varietà di habitat, tra cui praterie, foreste aperte e zone umide tropicali, probabilmente seguendo le grandi mandrie di erbivori che costituivano la sua principale fonte di cibo.
Enocione o Metalupo?
La notizia ha fatto subito il giro del mondo: alcuni articoli hanno però parlato di metalupo mentre altri di enocione.
Ma l’Enocione e il Metalupo, sono lo stesso animale? Sì, Canis dirus e Aenocyon dirus si riferiscono alla stessa specie estinta, comunemente nota come metalupo o “lupo terribile”.
La denominazione scientifica ha una storia un po’ complessa ma penso ne valga la pena raccontarla.
Canis dirus fu il nome scientifico originariamente assegnato alla specie da Joseph Leidy (il primo studioso di dinosauri nel Nuovo continente) nel 1858. Per molti anni, questa è stata la classificazione accettata e ampiamente utilizzata.
Nel 1918, il paleontologo John Campbell Merriam propose di classificare il metalupo in un nuovo genere, chiamandolo Aenocyon dirus. Il nome del genere deriva dal greco “ainos” (terribile) e “cyon” (cane/lupo), riflettendo le dimensioni e la reputazione dell’animale.

Due nomi per lo stesso animale che portano a un dibattito ancora in corso nella comunità scientifica riguardo alla classificazione più appropriata.
Alcuni ricercatori continuano a preferire il genere Canis, sostenendo che il metalupo è sufficientemente imparentato con altri membri del genere Canis (come il lupo grigio, il coyote e lo sciacallo).
Altri supportano la classificazione nel genere Aenocyon, basandosi su analisi morfologiche e, più recentemente, su studi del DNA antico che suggeriscono una divergenza evolutiva significativa del metalupo rispetto agli altri canidi del genere Canis. Uno studio del 2021 pubblicato su Nature sul DNA antico ha infatti indicato che il metalupo rappresenta una linea evolutiva altamente divergente rispetto ai lupi moderni che si separò dai canidi circa 5,7 milioni di anni fa. Un’ipotesi che porta a supporre che il metalupo abbia avuto origine ne Nuovo Mondo, quindi si sono evoluti in isolamento dagli antenati pleistocenici, mentre gli antenati dei lupi grigi, dei coyote e dei dhole (il cane selvatico asiatico) si sono evoluti in Eurasia per poi colonizzare il Nord America in tempi relativamente recenti.
© Riproduzione riservata
Photo-video credits:
© 2025 Quia Magazine: Metalupo1_AI_2025 (in copertina), Metalupo2_AI_2025, Metalupo3_AI_2025, Metalupo4_AI_2025